Quando si parla di effetto domino. Forse mai come durante questi due mesi di lockdown e di emergenza pandemica ci è stato chiaro quanto tutto sia interconnesso. Siamo una minima parte del tutto. Siamo interdipendenti. Siamo tutti fratelli e sorelle, volens nolens.
Ci sembrava così lontano questo strano virus, i racconti dalla Cina a febbraio avevano il carattere da film di fantascienza. Ci sentivamo immuni. Ci sentivamo divisi. Ci sentivamo forse anche invincibili; noi qui e quegli altri lì.
In varie occasioni in cui per lavoro ho avuto l’opportunità di raccontare di paesi, culture e situazioni diverse dalla nostra, mi sono resa conto di quanto poco sia presente nelle menti di molte persone, la consapevolezza dell’esistenza di molteplici realtà diverse dalla propria. Tendiamo a isolarci in ciò che conosciamo, qui e ora. Andare oltre noi stessi, relativizzare la nostra quotidianità e i nostri valori, ci riesce difficile per qualcuno addirittura inimmaginabile. Questo mi preoccupa e mi fa paura, ma soprattutto mi fa riflettere e mettere in discussione la legittimità del nostro modo di approcciare certe situazioni.
La solidarietà è possibile solo nel momento in cui io persona o comunità riesco a cogliere consapevolmente l’esistenza e il valore dell’altro diverso da me, e solo allora posso contribuire a quel processo di aiuto reciproco così fondamentalmente umano, così fondamentalmente prezioso per l’evoluzione globale. Ed è proprio la consapevolezza dell’esistenza di una realtà diversa dalla mia, che mi arricchisce umanamente, perché allarga i miei orizzonti, un orizzonte che altrimenti si fermerebbe alla punta del mio naso. Possiamo girarla come vogliamo, l’altro è ricchezza! Accettare che “nessun uomo è un’isola”, per citare John Donne, è l’unica via possibile per uscire dalla crisi, umana, economica, culturale. Finché staremo lì a scagliare le pietre contro gli altri, a cercare ostinatamente “il colpevole”, finché ci focalizzeremo soltanto sul problema senza andare oltre, potremo fare solo peggio.
È da oltre due mesi ormai che non si fa altro che parlare di virus, di epidemia, di crisi, di danni economici e di disastri sociali, come se non ci fosse un domani. Ed è un discorso quasi interamente concentrato sul “nostro” mondo “occidentale”, un mondo privilegiato, dall’economia sviluppata, dai mercati più o meno stabili, un mondo ordinato e ottimizzato.Con estrema serietà come se la verità al mondo fosse una sola, continuiamo a recitare il padrenostro del lockdown: social distancing, igiene, mascherina, test. Ci preoccupano le certificazioni delle mascherine, il rifornimento di gel disinfettanti, i testi, le distanze minime. Arriviamo alla punta del nostro naso e non riusciamo a focalizzare più in là.
C’è una massiccia parte di mondo là fuori invece, che non è privilegiata come lo siamo noi. C’è una massiccia parte di mondo là fuori che non ha accesso all’acqua potabile. Non ha accesso a servizi igienici. Non ha la possibilità logistica di chiudersi in casa, perché una casa non ce l’ha. Non ha la possibilità reale di mantenere un metro di distanza, perché quei 5 metri quadri di terra coperti da lamiere che chiama casa, li condivide con altre dieci persone. C’è una massiccia parte di mondo là fuori che se ogni giorno non esce per andare al mercato a vendere le proprie verdure, non sa come sfamare i propri figli la sera.
Guardando la mappatura mondiale dei casi di Covid nel mondo, sembrano essere pochissimi quelli nel sud globale, in particolare in Africa. C’è chi dice che è dovuto alla popolazione molto giovane, alla situazione climatica più favorevole perché fa più caldo. Se però facciamo anche solo un minimo sforzo, capiamo che in Africa – e dico Africa pensando a molte altre parti del mondo in situazioni simili – il sistema sanitario è inesistente. Non c’è uno stato sociale. Milioni e milioni di persone vive in slums e baraccopoli. Milioni e milioni di persone vivono alla giornata. In Africa non è una questione di collasso dei reparti di terapia intensiva, perché nella maggior parte dei casi i reparti di terapia intensiva sono inesistenti. In Africa l’obbligo di lavarsi le mani più volte al giorno e praticare il “social distancing” sembra solo una barzelletta di cattivo gusto. In Africa non fa differenza se muori di malaria, di influenza, di HIV o di Covid, tanto non hai possibilità di scampo comunque. In Africa non è questione di “gruppo a rischio” per gli anziani, perché l’aspettativa di vita è la metà della nostra.
Le nostre frontiere chiuse sono un’illusione di sicurezza e protezione per noi privilegiati. Per chi dall’altra parte del mondo avrebbe necessità di cibo, di materiale sanitario, di solidarietà, di aiuto ancora più di noi, le frontiere chiuse e le catene di fornitura spezzate, sono una condanna. Le nostre frontiere chiuse sono una vittoria per i populisti e una sconfitta per i nostri valori europei, valori umani. L’illusione che un virus si fermi alla sbarra chiusa e alla guardia che chiede di identificarsi, rimane un’illusione nel perverso tentativo di convincerci che con quegli altri non abbiamo nulla in comune. Questo non significa certo che dovremmo smetterla di fare il possibile per superare al meglio questa crisi, significa solo che dovremmo farlo senza dimenticarci mai degli altri nostri fratelli, delle altre nostre sorelle.
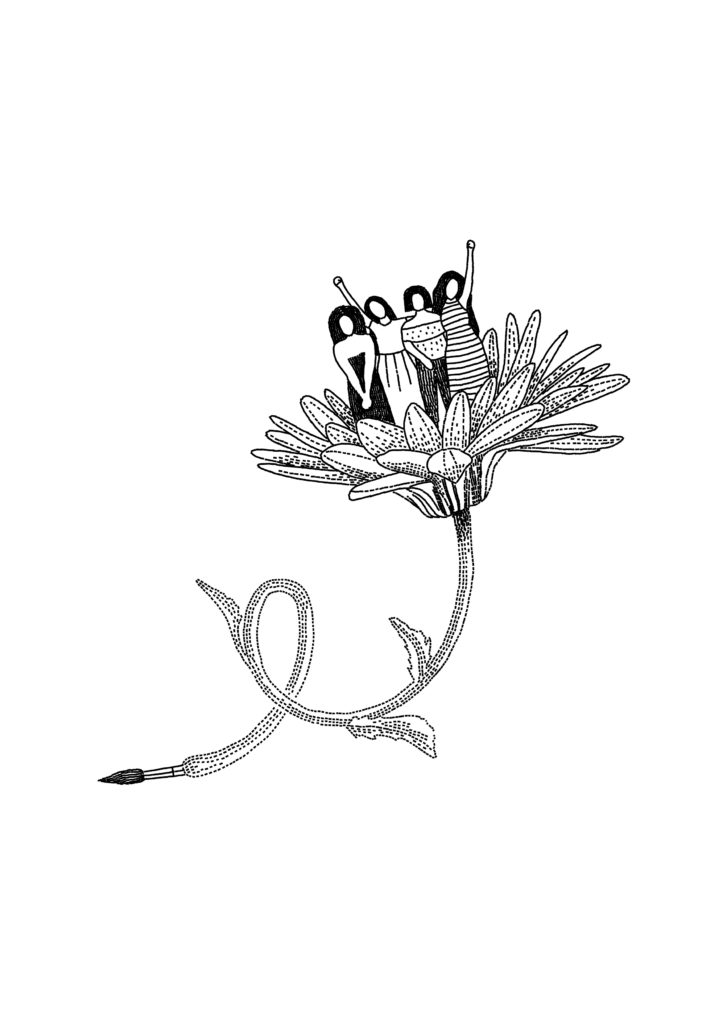
Lascia un commento